Il passaggio da un anno all’altro è forse il momento più interessante per osservare il nostro rapporto con i social network. Negli ultimi giorni di dicembre cadono le feste, le corse per fare i regali e quelle per chiudere le questioni di lavoro prima delle vacanze, quando nessuno risponde alle email. È un periodo stressante che si porta dietro il carico dei mesi precedenti, controintuitivo se si pensa che in natura tutto riposa nel pieno dell’inverno. In quei giorni basta entrare su Instagram per vedere una pletora di post che fanno il “recap” dell’anno passato: caroselli di foto in cui si tirano le fila di quel che si è fatto, di cosa ci hanno insegnato quei mesi, delle selezioni dei propri successi lavorativi e personali. Sembra quasi che senza quel post, per molti, l’anno non possa chiudersi, che quel gesto online gli dia un senso.
Gennaio invece è per molti il mese del detox: come chi aderisce al dry January e alle diete più svariate, molti scelgono di “disintossicarsi” dai social. Secondo uno studio condotto da NordVPN, gennaio è di gran lunga il periodo più popolare per disconnettersi dai social media. Stando ai dati raccolti sulla popolazione degli Stati Uniti l’anno scorso, il numero di ricerche su come eliminare Facebook è aumentato del 67,6% solo nel primo mese del 2025. Nello stesso periodo, le ricerche su come cancellare WhatsApp, Instagram e Snapchat sono cresciute rispettivamente del 56,6%, 42,6% e 19,6%.
Il punto è che spesso, se ci si pensa, quelli che decidono di fare il detox sono le stesse persone che a fine dicembre fanno il recap dell’anno. Non necessariamente chi passa troppo tempo sui social, ma piuttosto chi sui social conduce una sorta di seconda vita, che richiede energie quasi quante ne richiedono alcuni aspetti della nostra vita offline.

Per anni abbiamo cercato di capire il nostro rapporto con i social network contando minuti, notifiche, ore di schermo. Abbiamo trasformato l’esperienza digitale in una questione di quantità: quanto tempo passiamo online, quante volte sblocchiamo il telefono. L’idea implicita era che il problema, se c’era, dovesse emergere da un eccesso misurabile, visibile. I test più usati per capire se si ha una dipendenza dai social come l’Internet Addiction Test (IAT) e la Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) sono molto orientati su quantità e compulsività.
Negli ultimi anni, però, una parte crescente della ricerca psicologica sta mettendo in discussione questo approccio. Certo, il tempo conta, ma spiega solo una parte del fenomeno. Sempre più studi suggeriscono che il nodo centrale non sia tanto quanto usiamo i social, ma che ruolo permettiamo loro di occupare nella nostra vita, e quindi il valore psicologico, emotivo e simbolico che carichiamo sulle piattaforme.
In questo cambio di prospettiva si inserisce la Plan-net 25, una scala psicologica ideata nel 2025 da un gruppo di ricercatori attivi in Spagna e pubblicata su BMC Psychology, testata su un campione di 2.477 adolescenti tra i 12 e i 20 anni. L’obiettivo dichiarato dello studio non è misurare la dipendenza in senso classico, né individuare un uso “eccessivo” in termini quantitativi, ma valutare la sopravvalutazione dei social media.
La Plan-net 25 si inserisce in una linea di ricerca più ampia sulle dipendenze comportamentali e da sostanze, dove da tempo si è osservato che il problema risiede nel modo in cui il cervello valuta le ricompense di un comportamento, piuttosto che la frequenza con cui questo si ripete. Studi su droghe e gioco d’azzardo mostrano che le persone con dipendenze tendono a sopravvalutare il beneficio atteso di un’azione, l’effetto della sostanza o la vincita potenziale, rispetto ad alternative più sane, anche quando l’esperienza reale si rivela meno gratificante di quanto previsto. Questo squilibrio produce un bias decisionale: il comportamento sovrastimato viene scelto sempre più spesso, fino a occupare uno spazio sproporzionato nella vita quotidiana.
Secondo gli autori dello studio, un meccanismo analogo può essere osservato anche nell’uso problematico dei social media, che possono diventare oggetto della stessa distorsione cognitiva: la convinzione che offrano una forma di gratificazione più immediata ed efficace rispetto ad altre opzioni. In questo senso, il problema non è l’uso intenzionale dei social, ma il fatto che, nel nostro processo decisionale, il loro valore venga sistematicamente sovrastimato rispetto ad alternative come l’interazione faccia a faccia, il riposo, l’attività fisica o il tempo non mediato. Per dirlo in altre parole, se mi trovo spesso a preferire una serata passata a scrollare su Tiktok a una serata con gli amici, c’è qualcosa che non va.
Per rendere visibili queste distorsioni, simili nella struttura a quelle osservate in altre dipendenze, ma declinate nella vita quotidiana digitale, che gli autori ricorrono a un’immagine culturalmente radicata: quella dei sette peccati capitali. Questo schema è servito a descrivere i principali ambiti, i cosiddetti “domini di utilità”, in cui i social tendono a essere sopravvalutati.
La superbia si manifesta quando autostima e senso di valore personale diventano contingenti al riconoscimento online, quindi quando il numero di like, commenti o follower si trasforma in un indicatore di valore personale. L’invidia emerge attraverso confronti sociali persistenti, alimentati da contenuti curati che distorcono la percezione di ciò che è normale, e che intensificano in noi sentimenti di inadeguatezza. L’avarizia descrive l’accumulazione di attenzione e visibilità, quindi ancora like, follower, engagement, trattati come un capitale da custodire e far crescere.
La gola rappresenta il sovraconsumo informativo ed emotivo, un’ingestione continua di contenuti che ci satura più che nutrirci. La lussuria viene reinterpretata come la ricerca compulsiva di stimolazione immediata e gratificazione sensoriale, favorita da una struttura del social che premia la novità e l’intensità, riducendo progressivamente la tolleranza alla noia. L’accidia indica una forma di passività cognitiva: l’uso automatico e disimpegnato dei social come strategia di evitamento psicologico. A queste si aggiunge l’ira, che riflette la reattività emotiva e la polarizzazione incentivate da dinamiche algoritmiche che premiano l’indignazione e il conflitto.
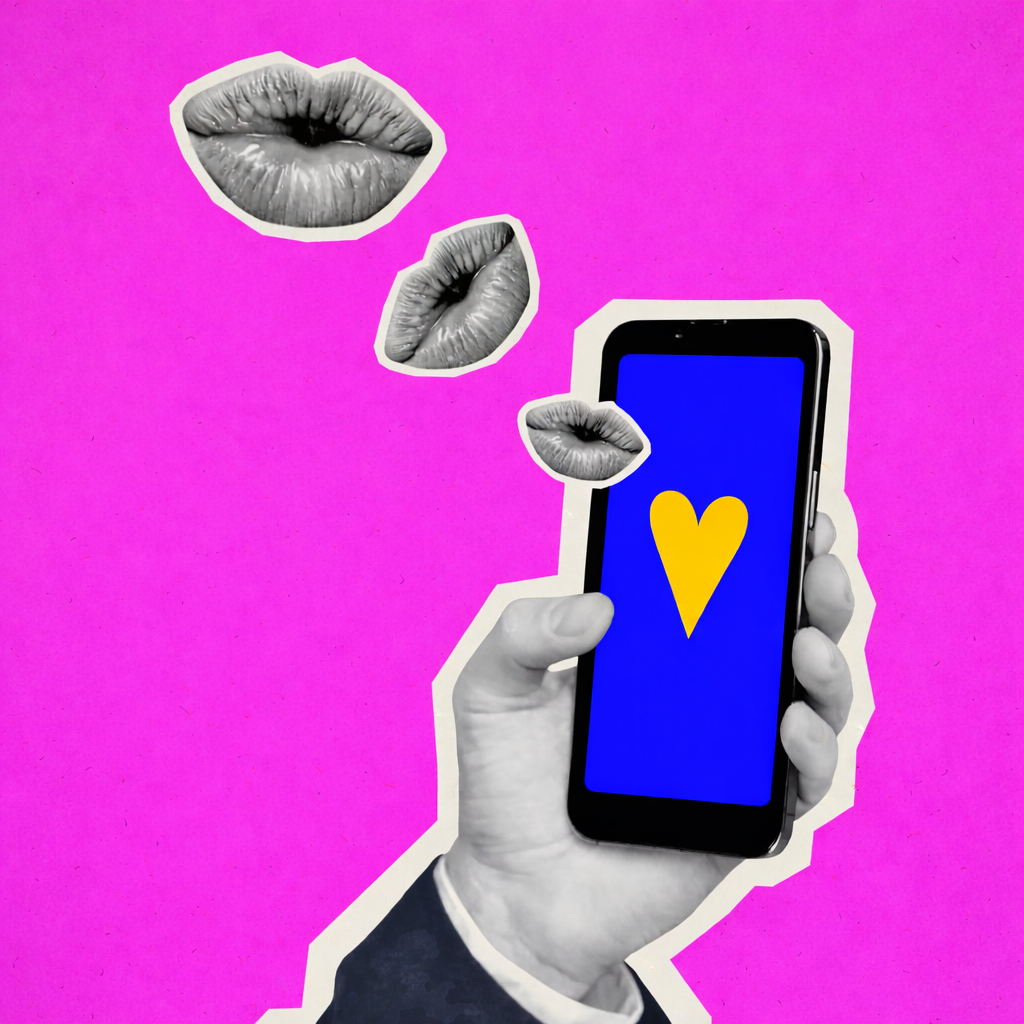
I risultati dello studio hanno confermato l’importanza della sovrastima: i ricercatori hanno osservato che chi presentava alti livelli di sopravvalutazione dei social, in particolare nei domini corrispondenti ai sette peccati capitali, mostrava anche una maggiore associazione con ansia, depressione, solitudine e insoddisfazione generale, oltre a una bassa autostima. I domini più fortemente correlati a effetti negativi sono stati la superbia, l’invidia, e la gola, mentre altri, come l’accidia, si sono associati a un utilizzo passivo e automatico, comunque collegato a una maggiore insoddisfazione.
Ovviamente il risultato non è uniforme: alcuni adolescenti attribuiscono un’eccessiva importanza solo ad alcuni domini, mentre altri mostrano una sopravvalutazione più generalizzata. Questo suggerisce che le strategie di intervento, come il detox digitale o le campagne di educazione all’uso consapevole, dovrebbero tenere conto non solo del tempo online, ma delle motivazioni e dei bisogni psicologici che i social vanno a soddisfare. Lo speranza degli studiosi, come segnalano loro stessi nel testo, è che la scala venga adattata e testata anche sugli adulti, tradotta in altre lingue e testata in contesti culturali diversi.
Ma da dove nasce questa sopravvalutazione? Lo studio si limita ad analizzare dei fattori preesistenti di vulnerabilità emotiva, ma non ci parla della società nella quale questo si verifica. Una società in cui i social media hanno superato già da qualche anno gli altri media come forma principale di informazione, adesso anche in Italia. Una società in cui i politici annunciano guerre con un post su X.
Potremmo ipotizzare che in molti casi sovrastimare i social sia una risposta a un ecosistema che spinge in quella direzione. Nel mondo del lavoro, ad esempio, una buona presenza online è sempre più spesso trattata come un valore aggiunto. Questo avviene in particolar modo in settori come comunicazione, creatività, media o moda, ma si sta espandendo anche ad altri settori. Non è raro che un profilo Instagram o LinkedIn venga implicitamente valutato durante un colloquio. Per tanti è diventato un secondo CV, da lì i post di recap sui propri successi lavorativi, fatti probabilmente più per necessità che per piacere.
Anche l’uso dei social contro la solitudine purtroppo ha basi concrete. Le piattaforme offrono la possibilità di avere un contatto e delle micro-interazioni che possono fare la differenza senza tanto impegno, in delle città in cui è sempre più difficile trovare degli spazi comunitari che siano accessibili a tutti.
Il paradosso del recap di dicembre e del detox di gennaio segnala una relazione ambivalente: i social sono allo stesso tempo lo spazio in cui cerchiamo un senso, e quello da cui sentiamo il bisogno di fuggire quando il peso diventa eccessivo.
Oltre alla società, non dobbiamo scordarci di osservare le architetture di queste piattaforme, studiate fino all’ultima funzione per alimentare in noi quegli effetti riassumibili nei sette peccati capitali. Chi gestisce i social network non farà niente per renderle meno assuefacenti , quindi purtroppo il lavoro spetta a noi. E il vero detox non consisterà nello sparire per qualche settimana, ma nel rimettere in discussione il valore che gli attribuiamo, chiederci cosa manca là fuori che cerchiamo lì dentro.
Viola Giacalone