Qualunque sia la vostra età, è difficile che vi sia sfuggito il concetto fondamentale che la ricchezza non è equamente distribuita nel mondo. Bene, lo stesso vale per l’intelligenza artificiale. Che non significa Chat GPT, ma potenza di calcolo, data center, energia, dati, competenze, regole e possibilità. Non mi riferisco solo a chi ha accesso a cosa, ma a una classificazione netta: chi può costruire, chi può solo utilizzare e chi resta fuori dai giochi prima ancora di iniziare. Se è vero che dove c’è Barilla c’è casa, è vero anche che dove c’è ricchezza c’è progresso (ma su questo torneremo più tardi). Avrebbe mai potuto essere altrimenti? La risposta, per quanto triste, è no. Ma il punto è che la maggior parte di noi ignora quasi del tutto cosa questo realmente significhi.
Mentre l’economia globale si sta orientando giorno dopo giorno verso un utilizzo massiccio di IA, i paesi meno sviluppati rischiano di restare ancora più indietro, alimentando divari economici e sociali che, se già erano voragini, stavolta rischiano di diventare buchi neri.
Non serve essere degli esperti per accorgersene: ogni giorno, sempre più pezzi della nostra vita si spostano dal mondo fisico a quello digitale. L’interazione uomo-macchina, che fino a pochi decenni fa altro non era che appannaggio di pochi registi e scrittori visionari, sta diventando centrale in quasi tutto quello che facciamo (e ciò che manca all’appello verrà con ogni probabilità risucchiato prima che ce ne accorgiamo).
Il problema è che l’intelligenza artificiale, per come la stiamo costruendo oggi, sta aumentando il benessere e i privilegi di vite, come le nostre, la cui qualità è già alta.
Ma tutti gli altri?
Partiamo dall’energia. Secondo l’International Energy Agency, nel 2024 i data center hanno assorbito l’1,5% dell’elettricità globale (più o meno 415 TWh, ovvero l’equivalente di 150 milioni di abitazioni alimentate per un anno) e, nello scenario attuale, entro il 2030 potrebbero arrivare a circa 945 TWh. Ciò che deve essere chiaro, è che questo è tutt’altro che un consumo distribuito: stando ai dati IEA, nello stesso 2024 la quota più alta era legata agli Stati Uniti (45%), poi alla Cina (25%) e in coda all’Europa (15%).
A questo punto, la domanda è: i paesi più piccoli e con meno risorse, privi delle infrastrutture necessarie a far fronte a una richiesta energetica di questa portata, come dovrebbero riuscire a entrare in gioco seguendo regole (ça va sans dire) dettate da noi? E no, non è la selezione naturale di Darwin (come ho sentito dire con disarmante leggerezza), perché qui di naturale non c’è niente.

Pensiamo all’acqua, l’altro elefante nella stanza. L’IA non consuma acqua perché è cattiva, la consuma perché i data center vanno raffreddati e l’energia in qualche modo va prodotta. Uno studio il cui titolo è Come rendere l’IA meno assetata, mostra come la water footprint dell’intelligenza artificiale (cioè la quantità di acqua dolce utilizzata direttamente e indirettamente per produrla) sia tutt’altro che trascurabile, e soprattutto quanto sia invisibile nel racconto pubblico. Se questo sta già mettendo sotto pressione anche le economie più solide, immaginate cosa succede dove l’elettricità non è stabile e l’acqua è già un problema strutturale.
Cerchiamo di essere onesti: quante volte la tecnologia ha portato con sé più danni che benefici, anche se adottata con le migliori intenzioni? Sta già facendo tremare il mercato del lavoro; per quanto riguarda la sanità sì, l’IA può salvarti la vita, ma può anche farti trattare come un numero; e il cervello umano? Ricordate Limitless, il film del 2011 in cui Bradley Cooper prende una pillolina che gli permette di sfruttare il 100% delle sue capacità cognitive? Ecco, è come se l’IA fosse l’antidoto che gradualmente le neutralizza. Il rischio che corriamo non è che ci faccia diventare tutti stupidi, è ben più sottile e umano: se continuiamo a usarla come stampella, se smettiamo di esercitare giudizio e fatica, il nostro cervello, come tutti i muscoli, inizierà a perdere tono (spoiler: ha già iniziato). In letteratura questa cosa ha un nome poco cinematografico ma molto concreto: automation bias, cioè la tendenza a fidarsi troppo del suggerimento della macchina anche quando sbaglia. E quando ti abitui a delegare, il passo successivo è che non ti alleni più a verificare.
Senza contare che dobbiamo costantemente chiederci chi controlla tutto questo, perché senza regole chiare l’IA rischia di diventare un Far West digitale dove comandano i soliti noti. Che stia arrivando il momento di aprire gli occhi? Il futuro dell’intelligenza artificiale non si scriverà da solo, e sarebbe in ogni caso auspicabile che ad occuparsene non sia solo chi venera il Dio denaro.
È evidente che negli ultimi decenni, soprattutto nel campo delle tecnologie digitali, le aziende private siano riuscite ad accaparrarsi il posto di principali motori delle innovazioni trasformative, agendo spesso e volentieri con una supervisione sociale diretta rasente lo zero. Questo contrasta ad esempio con l’approccio adottato dal CERN di Ginevra riguardo al World Wide Web (o come tutti noi lo conosciamo, il www.). Il 30 aprile 1993, invece di brevettare o privatizzare il codice sorgente del web, il CERN lo ha reso liberamente accessibile al pubblico. Questo gesto ha garantito che il web rimanesse una piattaforma aperta per l’innovazione e la collaborazione globale, libera da restrizioni proprietarie. Adottando questo approccio, il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare (il CERN, appunto) ha consentito e sta ancora consentendo la crescita di Internet, creando infinite opportunità per le imprese, l’istruzione e la comunicazione in tutto il mondo. Spoiler: questa eredità sta morendo per colpa dei modelli di sviluppo tecnologico a cui assistiamo tutti i giorni.
Per essere chiari: visto e considerato l’enorme impatto sociale che l’intelligenza artificiale sta avendo, l’adozione di un approccio senza scopo di lucro (udite, udite), che pensi a infrastrutture, dati e competenze anziché ai profitti, farebbe tutta la differenza tra un salto di qualità reale e l’ennesima redistribuzione al contrario. Utopia? In questi tempi bui sembra di sì.
Proviamo per una buona volta a partire dal presupposto che demonizzare l’intelligenza artificiale di default non abbia senso, perché i vantaggi effettivi che offre sono a dir poco mastodontici. Per dirla con l’OCSE: “l’IA ha il potenziale per affrontare sfide complesse, dal miglioramento dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria alla promozione dell’innovazione scientifica e dell’azione per il clima”. Quindi, la questione non è come tornare a prima, ma come far sì che il dopo sia migliore per tutti e non solo per noi. Perché al momento viviamo in un mondo in cui (passatemi la metafora basata su dati reali) uno affonda, tre nuotano controcorrente, cinque stanno a galla, e uno viaggia su uno yacht. Se il progresso tecnologico non viene gestito con cura e testa, chi è ricco diventerà più ricco, chi arranca continuerà ad arrancare e chi muore di stenti continuerà a morire. E mentre gli investimenti e la narrativa sull’IA promettono guadagni economici da migliaia di miliardi, la torta resta nelle mani di pochi. Secondo UNCTAD, il mercato globale dell’intelligenza artificiale potrebbe arrivare a 4,8 trilioni di dollari entro il 2033, grosso modo il valore dell’economia tedesca. Ma la domanda da porsi è: se l’IA ha il potenziale di creare uguaglianza, perché la stiamo usando in un modo che non farà che aumentare le disuguaglianze di sempre e lo stiamo chiamando progresso? Il progresso dov’è?
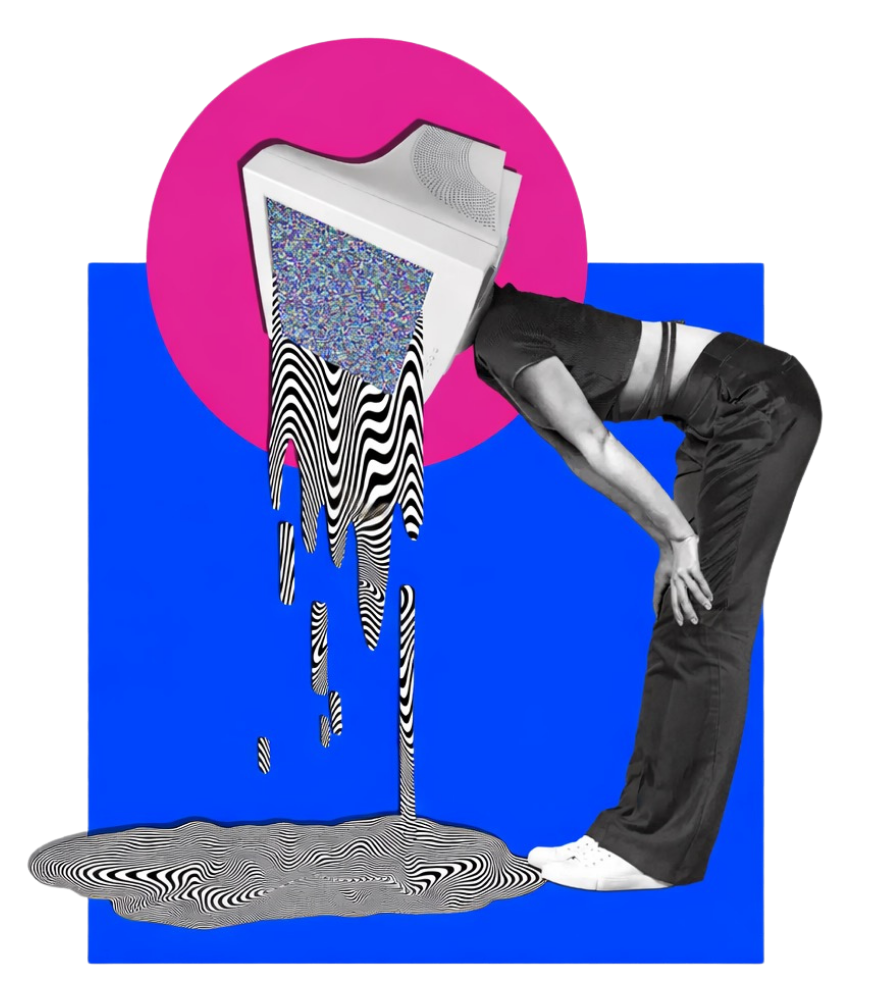
Il problema, poi, sta a monte; ovvero nel fatto che una certa parte di mondo (che la vogliamo chiamare Global South o meno qui poco importa) continua a fronteggiare un divario latente e persistente nell’accesso e nell’uso di Internet. Il concetto chiave è che il divario digitale si è evoluto da un’idea binaria di “connessi vs non connessi” a un fenomeno multidimensionale. Già nel lontano 2006, il gap digitale veniva descritto come un fenomeno stratificato, più che come una semplice separazione binaria: è vero che conta l’accesso alla rete, ma contano anche costi, qualità, genere, competenze e opportunità d’uso.
Oggi, secondo l’ITU, circa 2,6 miliardi di persone sono ancora offline (il 32% del pianeta). E la forbice è brutale: il 93% online nei paesi ad alto reddito contro il 27% nei paesi a basso reddito. Se poi ci aggiungiamo il gap interno tra aree urbane e rurali, perché cambiano infrastrutture e continuità del servizio, otteniamo il dato di fatto: non è che manca Internet, è che manca un ecosistema che renda l’online praticabile per tutti allo stesso modo, perché nessuno si è di fatto mai davvero impegnato per realizzarlo.
Aggiungiamo pure un pizzico di disuguaglianza di genere che non guasta mai, così il quadro diventa ancora più roseo: in paesi a basso reddito, circa il 90% delle donne tra 15 e 24 anni non può usare Internet, contro il 78% dei coetanei di sesso maschile. Non abbiamo percezione, nella nostra quotidianità agiata, di quante siano le persone tagliate fuori da un mondo che ormai viaggia quasi tutto sul digitale, e a una velocità a cui riusciamo a star dietro a malapena noi (noi, definizione: élite con accesso digitale completo).
Senza interventi mirati e coordinati per colmare il divario, il potenziale dell’intelligenza artificiale di dare un assist sia allo sviluppo sostenibile che alla riduzione della povertà resterà una delle tante false promesse del nostro tempo, e ampie fasce della popolazione globale continueranno a essere dimenticate in virtù della nostra corsa all’oro.
Se vogliamo almeno provare a fare le cose diversamente, ci sono alcune condizioni minime (non eroiche, minime) che possiamo pretendere. Connettività e costi: non basta “la rete”, servono accesso economicamente sostenibile e qualità del servizio, altrimenti l’online resta un lusso. Compute access: Università, ricercatori e pubbliche amministrazioni dei paesi più poveri devono poter usare computer potenti (server, GPU, cloud) senza dipendere in modo squilibrato da poche grandi aziende private; se l’accesso alla potenza di calcolo resta troppo caro, vincolato o controllato da pochi, allora solo alcuni paesi e alcune aziende potranno davvero configurare l’IA, mentre il resto si limiterà a usarla alle condizioni decise da altri. Energia e acqua: efficienza, trasparenza e pianificazione; senza questo trio la partita si gioca dove l’energia e la capacità di raffreddamento sono abbondanti, e indovinate un po’ chi è che parte avvantaggiato. Competenze e genere: alfabetizzazione digitale e AI literacy, soprattutto dove il gap colpisce le giovani donne in modo sistemico. Governance: regole comprensibili e applicabili, responsabilità e conseguenze chiare. La negligenza non diventa progresso solo perché la ribattezziamo innovazione.
Che lo si voglia leggere come positivo o negativo poco importa, perché l’impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo sulla società resta comunque paragonabile solo a pochi, epocali momenti nella storia dell’uomo. Con la differenza non banale che la scoperta del fuoco, la Rivoluzione Industriale o l’automobile non hanno cambiato il mondo in soli 24 mesi.
In The Impossible, il film del 2012 che racconta lo tsunami che colpì la Thailandia quasi vent’anni fa, le persone vedono avvicinarsi il muro dell’onda da lontano e cercano di mettersi in salvo. La sensazione che ho è che anche noi pensiamo di essere sulla riva guardando l’onda venirci incontro, ma la verità è che siamo già sommersi sotto dieci metri d’acqua e non ci siamo neanche accorti dell’impatto.
Beatrice Galluzzo